Luigi Manzione_Crisi e critica

Jean Nouvel,Dentsu Tower, Tokyo, Japan, 1998-2003
Questo scritto costituisce la traduzione in italiano, aggiornata e rivista, dell’articolo “Image, séduction, promotion. Pour une critique architecturale au-delà du divertissement”, pubblicato sul n. 11 della rivista Le Visiteur (Parigi, 2008). Una prima versione del testo francese – “La critique, le marché, le simulacre. La critique architecturale est-elle nécessaire?” – è in corso di pubblicazione in Hilde Heynen, Jean-Louis Genard (a cura di), Critical tools, Bruxelles, La lettre volée (atti del colloquio internazionale “Critical Tools”, organizzato nel 2003 dal Network for Theory, History, Criticism of Architecture/neTHCA).
“Toute la vie des sociétés dans lesquelles règnent les conditions modernes de production s’annonce comme une immense accumulation de spectacles. Tout ce qui était directement vécu s’est éloigné dans une représentation.”
Guy Debord, La société du spectacle, Parigi, Gallimard, 1992 (1967)
La critica architettonica contemporanea è in crisi. È una constatazione o uno slogan? L’idea di crisi della critica – quindi dell’architettura e, per estensione, delle condizioni (sociali, economiche, politiche) nelle quali hanno luogo la prima e la seconda – non investe solo il presente. Si tratta piuttosto di un elemento costitutivo del fare (e pensare) architettura dall’inizio del Novecento, a partire dalla “distruzione creativa” promossa dalle avanguardie storiche (1). Discutere della crisi della critica equivale a parlare della crisi dell’architettura tout court: ad interrogarsi sulla sua condizione attuale, sui modi del progetto e della sua produzione, comunicazione e ricezione.
Crisi e critica: rotture di continuità disciplinare
La figura della crisi costituisce una categoria persistente in architettura, nella pratica come nel discorso. A partire dalla erosione progressiva dei principi del movimento moderno – all’interno dei congressi internazionali (CIAM) dal 1949 al 1956 – la parola crisi figura con continuità nel lessico del teorico e del critico, quale esplicazione/giustificazione di uno stato di disorientamento e di “perdita del centro”. Crisi e critica hanno peraltro la stessa origine etimologica; κρίσις e κριτική derivano dal greco κρίνω, “distinguere, scegliere, giudicare”. L’origine comune è confermata dalla nozione di crisi in senso epistemologico, dove il termine designa la fase in cui il corpus concettuale di una disciplina viene sottoposto a un giudizio che ne rimette in questione i fondamenti. Ma crisi non è solo sinonimo di impasse e di decadenza. In etimo, la parola rimanda anche ad una esperienza di elaborazione di metodi, concetti, procedimenti nuovi. Secondo questa precisa accezione essa sarà utilizzata nel seguito.
Crisi è un termine che denota, inoltre, una situazione di transizione, dove emerge la volontà o la capacità di penetrare l’opacità dell’esistente (lo “spessore opaco”, per mutuare l’espressione da Bernardo Secchi), alla ricerca di ragioni e motivazioni per fare e per pensare (2). Le condizioni di crisi, in quanto rotture nei paradigmi disciplinari della cultura architettonica, hanno segnato tutti i decenni a partire dalla ribellione interna contro l’ortodossia del moderno, quale si è esercitata nel corso dei CIAM dal 1949 (3). L’esperienza dei CIAM evidenzia la difficoltà di riconoscere come riferimenti viventi una serie di principi ridotti a semplici precetti, una costellazione di pratiche e di discorsi sterilizzatisi in ”strumenti di regressione”, terreno di coltura di esercizi formalisti e accademici, “apparato di celebrazione”(4).
Rivolgere lo sguardo sull’esperienza dei CIAM può aiutare a far luce sulla condizione attuale e le difficoltà che si incontrano, da una parte sul terreno della teoria, dall’altra su quello della produzione architettonica(5). L’emergere di nuove ricerche in architettura procede dalla sperimentazione su e a partire dalla crisi, intesa come soluzione di continuità con il recente passato (che è anche l’ultimo presente). Per citare alcuni momenti significativi in Europa dopo l’ultimo CIAM, si possono ricordare la riflessione italiana degli anni ’60 sulle “preesistenze ambientali” intorno ad Ernesto Rogers e alla rivista Casabella, e gli studi tipomorfologici degli anni ’60-’70, sulla base dei lavori di Saverio Muratori, Aldo Rossi e Carlo Aymonino. Queste tendenze collocano al centro del dibattito il rapporto del progetto con la storia e la memoria, in rottura con le esperienze della modernità radicale degli anni ’20 e ’30. Senza dimenticare, poi, l’irruzione del postmodern all’inizio degli anni ’80 (la Strada novissima alla Biennale di Venezia del 1980), fino al ripiegamento teorico degli anni ’90 (in direzione del pensiero filosofico, in particolare verso la déconstruction e i “nuovi classici” francesi: Derrida, Deleuze, Lyotard, Foucault; o, ancora, la filiazione da Guy Debord a Pierre Lévy, passando attraverso Virilio e Baudrillard); le esperienze, in parte in corso, tra residui di discorsività e narratività ed apertura di nuove frontiere (post-architettura o trans-architettura).(6)

Neil Spiller, “Riverslapper” Slamhound: Development model
Paradigmi del presente e implosione del nuovo
L’orizzonte della contemporaneità è sempre più permeato dalla categoria del post: post-modernità, post-storia, post-sociale, post-umano. La nozione stessa di architettura sembra resistere con difficoltà alla “postizzazione” globale, generalizzata in modo onnivoro dalla produzione discorsiva (ed estetica). Dopo l’esplosione del nuovo innescata dalle avanguardie, la situazione attuale – essendo post-architettura e trans-architettura solo due definizioni di una serie destinata probabilmente a moltiplicarsi nell’epoca del post – è caratterizzata piuttosto da un fenomeno di implosione del nuovo. Una sorta di libero corso all’impiego del nuovo, recuperato da qualunque passato (più o meno avanguardista), al di là di una precisa scelta etica o ideologica.
Con connotazioni profondamente diverse in rapporto alle strategie di invenzione dello high modernism (7), una specie di nuova modernità – post-post? – identifica il valore tout court con il nuovo, con la contemporaneità. Non è inutile sottolineare che una tale identificazione privilegia la superficie di quel valore fondativo, a detrimento della sua profondità, privilegiando un orizzonte di breve (o istantanea) durata. Il “presente permanente”, teorizzato da Paul Virilio (8), appare qui volgarizzato secondo un’accezione da cultura dello spettacolo. Opposta all’orizzonte di lunga durata proprio alla modernità, peraltro già pericolosamente minato dal tempo breve delle avanguardie storiche, l’identificazione del valore con la contemporaneità traduce non più la metafora del “nanus positus super humeros gigantis”(9), ma nient’altro che la cruda realtà di nani discesi – con una certa supponenza – dalle spalle dei giganti. L’identificazione del nuovo con la contemporaneità si presenta, da un lato, come imposizione (che produce l’obsolescenza rapida e definitiva di tutto ciò che precede) e, dall’altro, come condanna (che mostra il carattere insinuante della moda in quanto condanna alla novità, secondo Walter Benjamin). (10)
Questa implosione del nuovo si materializza, nel corso degli ultimi venti anni, secondo diverse declinazioni: decostruttivismi, architetture liquide, bloboidi, deformazioni polimorfe, costruttivismi modali di ispirazione monadica, generazione di modelli organici, ameboidi, tentacolari, etc. Metafore e figure proprie ad una direzione di ricerca in architettura, dai contorni imprecisi, non ancora cristallizata in una nuova tradizione di ricerca. La trans-architettura (11) o, ancora, il supermodernism (12) si fondano sull’impiego diffuso del computer come strumento primario di elaborazione poietica e sul ricorso alle geometrie topologiche quali matrici di forma architettonica.
In queste architetture, un’attitudine del tutto acritica di fronte all’esistente fa da pendant alla esuberanza delle invenzioni formali e dei dispositivi di configurazione spaziale. Dopo aver scoperto – trent’anni dopo Robert Venturi e Denise Scott Brown – la “complessità” e la “contraddizione”(13) del paesaggio urbano contemporaneo, gli architetti si sono dedicati con slancio a tentarne la mimesi nel progetto. Dispersione, atopia, caos: a costituire problema non è tanto, oggi, la retorica di queste condizioni, quanto la loro riproduzione pura e semplice.

Peter Eisenman, Bureaux Koizumi Sangyo, Tokyo, Japan, 1988-1990.
Le mutazioni in corso nelle città e nei territori sono ben reali, e tuttavia sfuggono in una certa misura alla nostra capacità di osservarle e comprenderle (la loro esistenza anticipa, comunque, lo sguardo degli architetti e degli urbanisti). Volerle negare significa chiudere gli occhi, il che però non vuol dire che occorra legittimarle attraverso il progetto, o glorificarle nel loro disordine apparente, così da renderle alla fine inoffensive, privandole del loro potenziale di rottura. Per sua natura, il progetto è (dovrebbe essere?) presa di posizione, sguardo orientato sul mondo, instaurazione di una differenza nella uniformità del mercato globale. La mimesi del caos è, in fondo, una tautologia, un atto gratuito che non ha bisogno di un autore per essere compiuto poiché il caos è già là. Del resto, basta percorrere le nostre periferie per rendersene conto. Agli architetti spettano, credo, compiti ben più difficili della replicazione dell’informe e dell’atopico. In questo senso, la teoria e la critica dovrebbero costruire i fondamenti di una rappresentazione diversa del mondo attraverso l’architettura, se è vero che il progetto non è solo produzione di forme, ma anche rappresentazione. A partire da un punto di vista critico e di opposizione, il progetto potrà rappresentare di nuovo la complessità e la contraddizione della realtà, senza limitarsi a riprodurne i caratteri esteriori, ma proponendo altri scenari possibili.
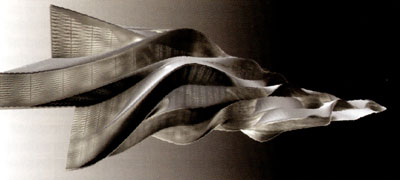
Karl Chu, Phylox 5
Ora, si assiste piuttosto alla proliferazione di un’avanguardia per così dire “senza principi”, che fa propria una mistica della diversità tutta giocata al livello della rappresentazione banalizzata e della pura immagine: del tutto conciliante e inoffensiva. Escludendo qualsiasi riferimento a un programma di (ri)fondazione disciplinare, necessario in un’era di grandi mutamenti come l’attuale, questi movimenti sembrano ruotare intorno ad una nebulosa di motivi essenzialmente speculativi, gli unici peraltro agevolmente praticabili nell’epoca della materialità frammentata e della civiltà numerica. Dall’oggetto architettonico al processo di creazione, tutto appare pensabile in termini di paradigma, mutazione, sinapsi (14). Tutto si riduce, insomma, ad una specie di cartografia del presente, rizoma ad entrate multiple che penetra nella profondità del significante, restando però alla superficie del significato. Pacificamente, confortevolmente. Si potrebbe dire: il massimo della seduzione, il minimo della fondazione…
Nonostante l’apparente effervescenza, il dibattito si ritrova in un impasse da più di venti anni. In una recente ripresa della riflessione in Italia, coloro che sono intervenuti hanno cercato di fare il punto sullo stato dell’architettura, sull’identità italiana e le sue prospettive future. Poco però pare emergere sul versante della costruzione di una visione d’insieme della disciplina: gli interrogativi sui temi decisivi della critica e della teoria restano ancora assenti. La ricerca di una teoria, l’elaborazione di un discorso fondatore (o, almeno, strutturante), la riflessione sulle ragioni – e non solo sugli effetti – del fare: niente di tutto ciò sembra emergere all’orizzonte. Dalla parte dei progettisti, tutto ciò che è al di fuori delle categorie dell’estetico – e che spinge, per certi versi, a sporcarsi le mani con la realtà – viene lasciato sistematicamente al margine. Nell’universo infinito della estetizzazione diffusa, il primato delle forme (15) (che nasconde, peraltro, una fobia dell’impuro) segna una linea di continuità tra postmodernismo, decostruttivismo, narratività e tendenze attuali in architettura.
Tutto viene ricondotto ad una questione di “stile”, e il ricorso alla transdisciplinarità diviene un espediente per mascherare una inquietante carenza di idee propriamente architettoniche (16). L’architettura si consolida, in sostanza, come produzione di minoranze per minoranze.
La critica tra panegirico e demistificazione
Qual è il ruolo della critica sull’orizzonte appena delineato? La mia ipotesi è che, a fronte delle sue responsabilità in un’epoca di trasformazioni radicali, la critica gioca oggi un ruolo di pretesto (e di pre-testo). Perduta ogni fiducia nel perseguimento dei suoi compiti tradizionali, sembra destinata a una funzione essenzialmente panegirica. Il suo fine ultimo è ormai quello di nobilitare pratiche progettuali del tutto separate da un lavoro fondativo, recuperando (talvolta ingenuamente) temi propri alle discipline scientifiche (biologia, ecologia, geometrie complesse, oggetti frattali, teorie del caos, etc.). Un nomadismo teorico, legato al gusto della transdisciplinarità per la transdisciplinarità, definisce il punto focale intorno a cui convergono gli oggetti, le figure e le immagini del paesaggio della critica contemporanea (17).
Quali sono allora i compiti della critica, ammesso che nella condizione contemporanea di relativismo diffuso sia ancora possibile parlare di “compiti”? Manfredo Tafuri – teorico, storico e critico oggi dimenticato in Italia – sosteneva che criticare significa “cogliere la fragranza storica dei fenomeni, (…) farne esplodere l’intera carica di significati”. Senza voler discutere il contributo sulle relazioni tra critica, storia, politica e linguaggio, il riferimento a Tafuri appare utile per indicare uno dei possibili compiti primari del critico: spiegare, diagnosticare con esattezza, fuggire il moralismo (18). Si misura qui la netta distanza rispetto alle preoccupazioni abituali dei critici di professione, che riducono l’architettura a pura e semplice materializzazione (e smaterializzazione) e alla comunicazione delle opere come eventi mediatici, senza porre in alcun modo la questione della “esemplarità” dell’architettura in quanto rappresentazione di una idea politica di città (19), altra dalla metropoli normalizzata del mercato. Di fronte al pluralismo superficiale, alla moda, e alla pseudolibertà attuale degli architetti, questa esemplarità non mi pare però possa incarnarsi in ciò che Pier Vittorio Aureli e Gabriele Mastrigli denominano “architettura assoluta” (20).
L’opposizione al pensiero unico del mercato globale non può dispiegarsi, a mio avviso, se non agendo nei suoi interstizi: non per mezzo di una antitesi totalizzante (la forma assoluta), ma piuttosto mediante una serie di operazioni progettuali “pazienti”. Azioni operanti sui margini, sulle fessure, sulle pieghe della omogeneità fittizia delle architetture spettacolari del mercato globale; azioni capaci di produrre exempla architettonici differenti. Credo che la costruzione di situazioni architettoniche singolari – rigorosamente definite nella loro valenza di esempio e nei valori (e conflitti) etici e politici che innescano – potrà contribuire a formare un’architettura critica, sulla quale una critica dell’architettura troverà materia di riflessione.
In questo contesto, il problema principale è la ricostituzione degli strumenti disciplinari. Ma si impone un salto di scala: dall’analisi degli oggetti architettonici alla critica dei contesti globali all’origine della loro configurazione; dal fluire continuo dello sguardo sul presente, all’attenzione paziente sul tempo della storia. L’interesse delle riflessioni di Tafuri risiede, in fondo, in una condizione che accomuna il suo tempo (la fine degli anni ’60) all’oggi: una forte distanza tra produzione architettonica e mondo reale. Al di là delle forme, è difficile non ritrovare analogie inquietanti tra l’architettura disegnata del neorazionalismo (in particolare Massimo Scolari e Franco Purini) e certe esperienze computer aided. Sul versante opposto, l’architettura utopica degli anni ’60 – v. Archigram – presupponeva un progetto politico – una visione radicale dell’abitare – di cui gli epigoni attuali credono di poter fare a meno. In una tale situazione di crisi dell’architettura, la possiblità della sua sopravvivenza sembra ancora sottomessa a due condizioni: che divenga autonoma rispetto al gioco degli interessi e della produzione, e che sia, inoltre, capace di ancorare il proprio discorso su un progetto politico credibile (21).
La riflessione storico-critica alimenta indubbiamente la teoria dell’architettura (e del progetto di architettura), ma non può essere assunta in maniera immediata come matrice – riferimento, modello, repertorio – del progetto, come auspica qualche esponente tardivo della critica operativa. La critica deve tener conto, da un lato, delle contraddizioni del contesto in cui ha luogo la produzione – essa costituisce un segmento delle “industrie culturali” di cui parlava Adorno – e, dall’altro, deve osservare i fenomeni attraverso il prisma della profondità storica. In questa prospettiva, per interpretare la realtà (e non limitarsi solo a ratificarla o negarla), la critica non può che essere demistificazione, attività permanente di “smascheramento” (secondo Tafuri). Ciò potrà aver luogo nel quadro di un progetto teorico suscettibile, pertanto, di divenire progetto storico. Come scriveva con lungimiranza De Solà-Morales, tutto si dà nella “possibilità di portare sulla scena la realtà, la dialettica del Potere, dei saperi, per contrapporla all’evanescente illusione dell’architettura” (22). Questa messa in scena rivela anzitutto un profondo sfasamento tra discorsi e pratiche, tra la produzione architettonica e la sua capacità di dispiegare effetti concreti sulle condizioni economiche e sociali. In un contesto di questo tipo (e nella illusione di poter fare a meno della dimensione del politico), l’atto critico diviene, a mio avviso, un’attività marginale, pericolosamente separata dalla realtà.
Schizonevrosi del discorso architettonico e ricostituzione di uno spazio critico
Alla sottoesposizione della cultura architettonica verso le condizioni concrete (quindi storiche) nelle quali si colloca, corrisponde una simmetrica sovraesposizione di fronte al discorso, in particolare ai discorsi filosofici. La cultura architettonica affronta tradizionalmente il discorso filosofico con una sorta di schizonevrosi, in cui la passività della ricezione – il fatto di rapportarlo al suo “territorio” senza alcuna mediazione, senza alcuno sforzo di appropriazione – si coniuga, paradossalmente, alla iperattività di quanti si ritengono capaci di costruire un apparato teorico mediante la ricomposizione ingenua dei frammenti di tale discorso (23). La critica si fa oggi secondo due modalità principali, che definirei il discorso sul discorso e il discorso come giustificazione. In entrambi i casi è assente un punto di vista realmente critico: rispetto agli autori, alle opere, ai contesti di produzione, commercializzazione e diffusione, alle mitologie, ai diktat del mercato. Ora, è proprio questa distanza, consapevolmente assunta, che può conferire un margine di efficacia al discorso critico.
Ma esiste oggi lo spazio per una critica in grado di non confondersi con l’oggetto che essa stessa promuove e veicola, che non rinunci alla presa di distanza rispetto alla realtà? Esiste lo spazio per una critica che non si identifichi senza mediazioni con il discorso (più o meno) filosofico attraverso cui essa cerca di fondare l’architettura, inevitabilmente esposta al contatto con la realtà, in un processo che tende puntualmente a contraddire l’ordine del discorso che le viene applicato a priori? Per rispondere a questi interrogativi sarà necessario anzitutto orientare lo sguardo su questa realtà, campo di produzione di fenomeni concreti (24) e, insieme, luogo di interazione e di collisione di rapporti di forza (economici, sociali, politici, culturali), oltre che terreno di elaborazione di discorsi teorici e di “oggetti” culturali.
Al di là delle etichette – “postmoderno”, “surmoderno”, “tardomoderno” (25) – l’epoca che viviamo riflette una mutazione culturale radicale, definita da Scott Lash come un processo, o paradigma, di “de-differenziazione” (26). In questo paradigma si osserva una perdita di autonomia reciproca tra le principali sfere culturali, con il risultato che l’estetico tende a “colonizzare” il teorico e il politico (27). La supremazia dell’estetico si produce parallelamente al debordare del culturale nel sociale, con l’abolizione di ogni limite tra la produzione e il consumo di immagini. La critica diviene un elemento di mediazione tra cultura e consumo, tra prodotto culturale e consumatore (che, in questo infinito sconfinamento, si fa “pro-sumer” (28), produttore e consumatore alla ricerca di un’alternativa alle merci anonime, standardizzate, massificate, per mezzo della interazione diretta con la produzione, delle nuove tecnologie di comunicazione, dello scambio no limit sul web).
Come aveva pronosticato Guy Debord, la realtà si allontana nella rappresentazione: la produzione artistica contemporanea tende a concettualizzare le rappresentazioni non più come qualcosa di problematico, ma al contrario di problematizzare la realtà (si veda il dominio dell’inorganico e del simulacro nell’arte contemporanea) (29) e di mettere in scena la cultura (con l’accento sulla relazione e la postproduzione) (30). La significazione assume l’immagine come veicolo prioritario, avendo già relegato la parola a ruolo di pura replicazione dell’immagine stessa, grazie a procedure di de-differenziazione generalizzata. L’architettura si avvicina, a sua volta, sempre più ad una installazione, per farsi “perfomance comunicativa” (31).
L’ipotesi che vorrei formulare è che, sul terreno dell’architettura, si verifica una de-differenziazione selettiva, nella misura in cui il processo che stiamo seguendo ha luogo solo in rapporto a certi campi specifici e/o termini di riferimento. Si produce, così, una sorta di omologazione del diverso, di ciò che – in un tempo e in uno spazio altri – era stato portatore di differenza. La nuova ondata (post-postmoderna?) innesca in architettura tre movimenti essenziali, sostituendo: 1) il riferimento al linguaggio moderno con un linguaggio “auratico” (32), sebbene volgarizzato (si veda la mistica dell’informazione, della simultaneità, del “presente permanente”) (33); 2) la ricerca dello high modernism con la ripetizione infinita dei tòpoi formali e discorsivi propri ai paradigmi culturali correnti, realizzando una produzione architettonica, più o meno mainstream, di qualità diseguale ma del tutto omogenea rispetto alla imagerie (spesso al limite di un conformismo del genere nuovo stile internazionale); 3) lo storicismo a 360 gradi del postmodernismo con uno storicismo per così dire “ristretto”, che recupera in maniera casuale alcune esperienze e figure delle avanguardie storiche, dello stile internazionale (34), del Team X, dell’architettura radicale degli anni ’60 (con l’attualizzazione, per così dire “levigata”, di questi riferimenti ad uso del pubblico di massa).
A fronte di un simile scenario di produzione (e ricezione) dell’architettura, non mi sembra anacronistico richiamare ancora la necessità della demistificazione propria all’atto critico, in quanto decostruzione, disseminazione e rimontaggio di frammenti attraverso il prisma della messa in prospettiva storica (35). Come ho osservato prima, il carattere demistificatorio dell’atto critico appare tanto più necessario quanto più si percorre il territorio della produzione attuale di pratiche e discorsi in architettura. Quale scenario, allora, per la critica contemporanea? Quale orizzonte possibile, nel momento in cui un intero repertorio concettuale e visibile sembra stagliarsi – in equilibrio instabile tra argomentazione e retorica – sul limite debole tra ricerche necessarie e profonde, da una parte, ed un nuovo manierismo (nella produzione, come nella riflessione), dall’altra, in propagazione planetaria alla velocità del bit. Questo limite rappresenta il luogo affatto reale in cui si gioca il senso del pensare e del fare architettura oggi, su cui la critica deve inevitabilmente portare il suo sguardo.
Peraltro, nella società dello spettacolo e nella declinazione mondializzata del capitalismo avanzato, è ancora ipotizzabile un’architettura critica, accanto ad una critica dell’architettura? A fianco ad una maniera di vedere l’architettura in grado di sostenere una distanza necessaria rispetto alla realtà, denunciando una visione dell’atto critico incapace di distaccarsi dal proprio oggetto (sia perché troppo lontano dalla materia di cui questo oggetto è costituito, sia perché troppo al di dentro di esso, in quanto pura promozione del prodotto architettonico). Si può porre, inoltre, la questione della possibilità (e della legittimità) di una ricostituzione dell’architettura (e della sua critica) come un campo di sperimentazione compreso tra i due estremi della critica della società (come era stata agitata dalle avanguardie storiche, e poi teorizzata dalla scuola di Francoforte) e della estetizzazione diffusa (vale a dire della legittimazione estetica a priori della produzione e del mercato)?

Toyo Ito, L’oeuf des vents, Okawabata River City, Japan, 1988-1991
Immagine, seduzione, promozione
L’estetizzazione del quotidiano si accompagna a un’attitudine definita come ’”iperrealismo contingente” (36), ad alto tenore mediatico, basata sulla mimesi del linguaggio dell’informazione, del nomadismo, del transito, dell’instabile, dell’ubiquo. Colta nel flusso di questa evoluzione continua, la figura dell’architetto perde progressivamente la consapevolezza del suo ruolo critico nei confronti dell’esistente, per diventarne una parte ben integrata (e pacificata). Il suo margine di manovra si riduce significativamente: diviene così sempre più un art director, destinato a forgiare l’immagine di marca del prodotto (in stretta relazione con gli imperativi della moda e della pubblicità, come dimostra, ad esempio, il progetto di AMO a fianco ad OMA di Rem Koolhaas). Azzerata ogni ambizione “auratica”, l’architettura si dissolve anch’essa in uno strumento di marketing, con la conseguente disseminazione di oggetti atopici che parlano solo il proprio linguaggio (in un monologo, se possibile, a due voci tra produttore globale e consumatore-individuo proprietario-habitué-di-shopping mall ed altri non luoghi). In un tale contesto, all’architetto si richiede di assicurare al prodotto introdotto sul mercato, in maniera flessibile, una necessaria costanza della prestazione, oltre che un’invenzione costantemente controllata, in linea con la fondamentale triangolazione immagine-seduzione-promozione (37).
La riproposizione dell’atto critico come demistificazione presuppone il superamento delle aporie che ho cercato di mettere in luce. Per riflettere sulle possibilità di ricostituzione di uno spazio della critica in quella che denominerei l’epoca dell’immagine-seduzione-promozione, non sarà inutile ritornare sul limite, sopra evocato, dell’equilibrio instabile tra argomentazione e retorica, dove la contraddizione si con-fonde con il paradosso. In apparenza, sembra delinearsi una illimitata accessibilità ai luoghi del sapere, così che chiunque abbia qualcosa da dire sull’architettura troverà, nel “villaggio globale”, il suo spazio di espressione (salvo, poi, a distinguere tra spazi pubblici e privati, tra diffusione della cultura e strategie di marketing puro e semplice…). Tutto appare raggiungibile, condivisibile, aperto. Nella situazione attuale di difficoltà della critica e di crisi dei suoi fondamenti, la sua utilità ed efficacia sono peraltro rimesse in discussione di fronte agli eventi che fanno la storia. Pensiamo all’assenza della critica riguardo alla ricostruzione di Ground Zero…
I temi prima indicati sono stati al centro dell’attenzione di architetti, storici, teorici. Senza ripetere qui ciò che è stato detto a proposito della condizione attuale – da Harvey, Virilio, Berman, Lash, Jameson, Giddens, Eagleton, Vattimo, Maldonado, Habermas, Touraine, Bourdieu, per non citare che alcune figure principali – non è inutile ripercorrere rapidamente le questioni riguardanti il paesaggio della critica contemporanea. È vero che viviamo in un “borderless world” (38), ma non mi sembra irrilevante tentare di reperire i limiti dei domini delle discipline, l’estensione dei loro campi di pertinenza. Sul terreno della critica architettonica, bisognerà forse ripartire da qui per definirne i compiti e gli statuti possibili, per progettare una transdisciplinarità che sia qualcosa di più di un semplice travestimento.
A partire da questo ordine di questioni, proporrei di distinguere – alla confluenza della teoria, della storia e del progetto – tra l’infinitamente possibile e il virtualmente necessario: ciò che è, in definitiva, il compito essenziale di una critica che vuole essere in grado di penetrare la cortina di omogeneità apparente, ma di fatto profondamente diseguale, che caratterizza la scena nell’epoca della mondializzazione mediatica (39). Nessun giudizio è possibile in assenza di distinzione e di scelta. Nessun atto critico è possibile quando la critica è condannata – dal mercato? dalla moda? dai critici stessi? – a giocare un ruolo di promozione, diffusione e consolidamento di autori ed attori, nei rapporti di forza interni allo star-system. È infatti evidente che, finché l’architettura accetta di ridursi alla invenzione di pure strategie di packaging, volte a fabbricare un’immagine pellicolare per “vestire” edifici (le cui regole di produzione e consumo vengono stabilite a priori, sulla base degli imperativi del mercato), la critica non può che restare vittima della viscosità stessa del processo. Per farsi un’idea, basta osservare ciò che è accaduto nell’architettura dei musei, il cui fine appare sempre di più quello di soddisfare le esigenze di un’economia globale di iperconsumo,(40) basata su strategie di marketing territoriale operanti nella logica delle “città globali”, ossessivamente rivolte a conseguire (o a non perdere) il predominio nella reciproca concorrenza, in particolare sul versante della sublimazione mediatica del genius loci ad uso del turismo di massa (a Bilbao come a New York, a Parigi come a San Paolo…). Quale ruolo potrà svolgere la critica nel momento in cui le agenzie (non specializzate) di viaggi organizzano tour nelle grandi città, non per farne visitare i luoghi e i monumenti, ma per far consumare i nuovi landmarks progettati dalle archistar (41)?
Critica (sovraesposta) e simulacro: quale scenario per la critica?
In un universo sovraesposto, dove tutto appare (illusoriamente) “trasparente” (42), la critica appare anch’essa errante e senza spessore. Perduta la percezione chiara dei limiti che definiscono il proprio campo, disegnandone una identità condivisa, la critica partecipa oggi largamente ad un processo di disseminazione generalizzata. L’autorità dei suoi veicoli tradizionali – i libri, le riviste, i convegni, etc. – è sempre più revocata in dubbio dalle migliaia di siti e fanzines proliferanti sul web. I numeri parlano chiaro, e sono tutti a favore delle riviste digitali. È senza dubbio ancora presto per formulare giudizi a proposito dell’irruzione della critica nei nuovi media. Tuttavia, lo sprawl del discorso critico sul web – connesso spesso in modo acritico alla attualità immediata dominante nelle news – ha aperto possibilità inedite alla riflessione, avendo favorito la presa di parola da parte di quanti non hanno (e non avrebbero probabilmente mai avuto) accesso ai media tradizionali. Ciò ha evidenziato la vulnerabilità di questi ultimi, con l’obsolescenza quasi istantanea dei contenuti da essi veicolati, soprattutto quando riflettono direttamente l’attualità.
La presa di coscienza di questa condizione avrebbe dovuto indurre le riviste cartacee a preferire il tempo lungo della riflessione rispetto al tempo breve del commento sull’attualità. Avrebbe dovuto condurre, inoltre, ad una riflessione più approfondita sui propri campi d’intervento (strategie editoriali, progetti critici, selezione degli architetti, dibattiti, etc.), allo scopo di creare una differenziazione visibile in rapporto alle riviste elettroniche. Non sembra che, in effetti, le cose abbiano finora seguito questa direzione, almeno se si guarda alle strategie promozionali, nelle quali la linea di frontiera tra le diverse posizioni ancora si riduce, spesso, al piccolo dilemma tra architettura reale o virtuale, tra dimensione artigianale o abilità informatica, al digital divide insomma. Tutto ciò esclude la possibilità di riconoscere e accogliere la moltitudine dei progettisti esterni allo star system, operanti sul versante dell’architettura più che su quello del mercato mediatizzato. A parte alcune eccezioni, il risultato appare piuttosto deludente per le riviste tradizionali, se si tiene conto del ruolo tutto sommato marginale a cui, nell’attuale contesto, sono destinate nella cultura architettonica e nella formazione delle giovani generazioni. Si aggiunga poi la diffusione sempre più pervasiva della sponsorizzazione sulle riviste stesse: le imprese di costruzioni, le società di promozione immobiliare, i produttori di materiali e tecnologie acquistano delle pagine – spesso le prime – per pubblicare progetti da loro realizzati, accompagnati da testi panegirici ed incredibilmente acritici (con un effetto di spaesamento per il lettore, sorpreso a sfogliare pagine dove progetti di architetti del tutto anonimi si alternano a quelli firmati dalle archistar).
In fuga dalla realtà o, al contrario, per un eccesso di realismo, la critica sembra non essere mai presente laddove il gioco della realtà ha luogo. È lontana, ripiegata su piccoli esercizi di retorica o su grandi operazioni di marketing; ma sempre sullo sfondo. Oggi la critica è un simulacro. Di se stessa e del suo oggetto, che non cessa di proliferare seguendo traiettorie di elaborazione spontanea, al di là dello sguardo del critico di professione, al di fuori di qualsiasi spazio di “pubblicità”, nel senso di visibilità pubblica, di dibattito e di confronto. La critica è lì, sulla distesa senza fine di un mercato sempre più globale e anonimo. Nella condizione contemporanea, in cui essa appare spesso assente; ordinariamente inefficace perché distante dagli interrogativi essenziali; quasi sempre inutile perché impegnata nella promozione dell’esistente (o di ciò che è in procinto di esistere) nei limiti invalicabili dello star system, una domanda radicale si impone, prima ancora di mettersi al lavoro per una possibile ricostituzione di un punto di vista critico: la critica è necessaria?
Luigi Manzione
Architetto, dottore di ricerca dell’università di Paris VIII, ha insegnato alla facoltà di architettura di Paris-La Villette dal 1997 al 2001. Oltre che di critica architettonica, si occupa di storia e teorie dell’urbanistica, delle forme insediative e delle trasformazioni del paesaggio della periferia europea contemporanea. Ha pubblicato su riviste e volumi collettivi in Italia, Francia e Belgio. Tra i suoi articoli recenti: “Économie du lien et biopolitique. Gaston Bardet et l’urbanisme comme science sociale” in Espaces et sociétés, n. 140-141, 2010, pp. 193-214; “Lire Bardet” in Urbanisme, n. 372, 2010 (in corso di pubblicazione); “La Roma di Gaston Bardet: lo sguardo di un urbanista francese negli anni trenta del Novecento” (di prossima pubblicazione in Urbanistica).
note
(1)Sull’immagine della “distruzione creativa” come strategia essenziale della modernità, in cui il presente si crea su/attraverso la negazione del passato, v. l’”angelo della storia” nel quadro di Paul Klee, Angelus Novus, citato da Walter Benjamin nelle Tesi di filosofia della storia (Benjamin 1955). Cfr. anche (Berman 1982) e (Harvey 1990). Qui e nelle note seguenti si riportano i riferimenti bibliografici come nella citata edizione francese.
(2)V. (Argan, 1964).
(3)Mi riferisco al processo di erosione della ortodossia del moderno “eroico” degli anni ‘20-’30, che porterà alla formazione del Team X. La rottura interna si consuma nel nono CIAM di Aix-en-Provence (1953), dove si delinea la critica della carta di Atene, con le posizioni, tra gli altri, di Aldo van Eyck, di Alison e Peter Smithson, di Giancarlo De Carlo, che oppongono le categorie relazionali dell’identità e della comunità alle quattro categorie funzionali della carta di Atene.
(4)(De Carlo, 1999).
(5)Difficoltà sottolineate da (Gregotti 1999), nel contesto di una visione estesa della contemporaneità, come momento proprio alla incompiutezza del “progetto moderno”, in riferimento a Jürgen Habermas.
(6)Cfr. (Masiero 2001).
(7)(Jameson 1984).
(8) (Virilio 1984).
(9)(Compagnon 1990).
(10)V. (Benjamin 1936.a).
(11)Il termine transarchitettura è stato introdotto da (Perrella 1998). Tra le figure che possono iscriversi in questo movimento si ritrovano, tra gli altri, Karl Chu, Marcos Novak, Sulatan Kolatan e William J. McDonald, Nox, UN studio.
(12)Sul concetto di “supermodernism”, v. (Ibelings 1998). Marcos Novak ha parlato di transmodernità come condizione di virtualità in senso tecnologico e filosofico. (Novak 2003, 141-155).
(13) (Venturi, Izenour, Scott Brown 1972).
(14)V. (Brayer 2000).
(15) L’inflazione dell’estetico si traduce, alla lunga, in un effetto narcotico: l’accumulazione di immagini produce assuefazione e indifferenza. Lo choc procurato al flâneur dal dinamismo della metropoli – nella descrizione di Georg Simmel e poi di Walter Benjamin – è ormai neutralizzato dall’“anestesia dell’architettura”. (Leach 1999).
(16)A proposito del tentativo di ricostituzione di un pensiero critico nel contesto del postmodernism cfr. (Ghirardo 1996), dove si sottolinea la marginalità della riflessione di fronte “ai processi reali di committenza, di finanziamento e di costruzione degli edifici”. Aggiungerei che questa marginalità è diventata ormai pienamente (e globalmente) effettuale.
(17)Ci si può chiedere se questo nomadismo teorico – inaugurato nell’ultimo quarto nel Novecento con le figure del rizoma (Deleuze-Guattari), del labirinto (Borges, Eco), della rete senza centro – rappresenti un paradigma di razionalità plurale o, al contrario, l’instaurazione di un nuovo conformismo epistemologico. Sulla ricostituzione della scena teorica in cui si situano i riferimenti citati, v. (Chiurazzi 1999).
(18)(Tafuri 1986, 3-4); v. anche l’introduzione a (Tafuri 1980). Il capitolo 6 di Teorie e storia dell’architettura è intitolato proprio “I compiti della critica”.
(19) V. (Aureli, Mastrigli 2007).
(20)Alla “metafisica del diagramma” (a partire da Le Corbusier), Aureli e Mastrigli oppongono una architettura assoluta: l’oggetto architettonico non sarebbe quindi il diagramma di un tutto, ma l’idea di un tutto nel suo carattere assoluto. Adottato all’origine comme una convenzione per la rappresentazione dell’architettura, il diagramma è diventato in seguito “lo strumento attraverso il quale è possibile ridurre od aumentare tutte le complessità e le contraddizioni del mondo in nome di una libertà legittimata dai sempre più sofisticati mezzi di produzione.” (Aureli, Mastrigli 2005.b). L’equivoco di una certa tendenza del pensiero architettonico contemporaneo risiede, secondo gli autori, nella proposta del diagramma come nuova iconografia della realtà – v. (Eisenman 2003) –, ossia come strumento di produzione e non di rappresentazione del progetto. Di qui, la deriva nichilista dell’architettura (più o meno virtuale), a cui Aureli e Mastrigli contrappongono la dimensione “effettuale” dell’oggetto architettonico nel suo valore di idea del mondo, prima ancora che pura rappresentazione. Sulla “metafisica del diagramma”, cfr. anche i contributi in (Any 1998).
(21)Ignasi de Solà-Morales discute questi temi in una ricostruzione tra le più sottili del pensiero di Tafuri (De Solà-Morales 2001).
(22)(De Solà-Morales 2001, 138).
(23)V. (De Solà-Morales 1999, 59). La teoria dell’architettura mutua i suoi riferimenti all’esterno (alle scienze umane, sociali, naturali, etc.), ma non accade quasi mai il contrario: lo scambio avviene a senso unico. Pochissimi intellettuali hanno focalizzato, anche solo di sfuggita, la loro riflessione verso l’architettura (penso, ad esempio, a Massimo Cacciari e a Jean Baudrillard); al contrario, numerosi sono gli architetti che si interessano di filosofia, con risultati più o meno significativi…
(24)Utilizzo l’espressione “campo di produzione” in riferimento a (Bourdieu 1991).
(25)Cfr. (Berman 1982), (Jameson 1984), (Harvey 1990).
(26) (Lash 1990); v. anche (Aureli, Mastrigli 2005).
(27)V. ancora (Lash 1990) per l’idea del postmoderno come “regime di significazione figurale”, in cui la significazione iconica (immagine) prevale su quella discorsiva (parola). Sulla centralità dell’estetica nei campi concettuali della vita, della forma, della conoscenza e dell’azione, cfr. (Perniola 1997).
(28)Cfr. (Töffler 1981).
(29)V. (Perniola 1996).
(30)V. (Bourriaud 1998) e (Bourriaud 2003).
(31) (Purini 2005).
(32)Nel senso dato da Walter Benjamin e, prima ancora, da Max Weber alla espressione “arte auratica”, ossia il fatto che l’estetico si costituisce – nella modernità – come un dominio separato. Il declino dell’aura – perseguito in primo luogo dai surrealisti – condurrà, secondo Benjamin, al riavvicinamento tra la sfera estetica e il mondo reale. V. (Benjamin 1936.b).
(33)(Nantois 2000).
(34)I punti di convergenza tra la produzione supermodernista nell’era della globalizzazione e l’International style (specie nei suoi esiti tra gli anni ’50 e ’60) sono stati individuati da (Ibelings 1998).
(35) Cfr. (Tafuri 1980), in particolare il capitolo “‘L’architecture dans le boudoir’”.
(36) (Gregotti 1994).
(37)Sulla smaterializzazione della metropoli in vista delle esigenze del mercato, cfr. (Ilardi 2002). Sulla nozione di non luogo, v. (Augé 1992). Sui rapporti tra cultura, architettura e marketing, v. (Foster 2002). Riguardo al dibattito sulle nuove forme della città, del territorio e dell’abitare metropolitano, cfr. tra gli altri (Ilardi 1997), (Ricci 1996), (Desideri 1997), (Pavia 1997), (Manzione 2000).
(38) (Ohmae 1990).
(39)Per temperare l’ottimismo riguardo alla indifferenza geografica delle opportunità offerte dalla globalizzazione, v. (Bauman 1998).
(40)Cfr. (Purini 2002); (Area 2002).
(41) Per la definizione di archistar, v. (Lo Ricco, Micheli 2003).
(42)V. (Virilio 1984) e (Vattimo 1989).
Riferimenti bibliografici
Argan, Giulio Carlo,“La crisi dei valori”, in G. C. Argan, Salvezza e caduta dell’arte moderna, Milano, Il Saggiatore, 1964.
Ashihara, Yoshinobu, The Hidden Order: Tokyo through the Twentieth Century, Tokyo, Kodansha International, 1989 (trad. francese: L’ordre caché: Tokyo, la ville du XXIe siècle?, Parigi, Hazan, 1994).
Augé, Marc, Non-lieux. Introduction à une anthropologie de la surmodernité, Parigi, Seuil, 1992.
Aureli, Pier Vittorio, Mastrigli, Gabriele, “Teoria e critica. Punto e a capo”, Arch’it. Rivista digitale di architettura, maggio 2005.
Aureli, Pier Vittorio, Mastrigli, Gabriele, “Oltre il diagramma. Iconografia, disciplina, architettura”, Arch’it. Rivista digitale di architettura, maggio 2005.b.
Aureli, Pier Vittorio, Mastrigli, Gabriele, “Con le armi della teoria. Architettura come progetto politico”, Arch’it. Rivista digitale di architettura, aprile 2007.
Bauman, Zygmunt, Globalization. The Human Consequences, Cambridge-Oxford, Blackwell, 1998.
Benjamin, Walter, Paris, die Hauptstadt des XIX. Jahrhunderts, 1936.a (trad. franc.: “Paris, capitale du XXe siècle”, in Écrits français, Parigi, Gallimard, 2003.
Benjamin, Walter, “Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit“, 1936.b (trad. franc.: “L’oeuvre d’art à l’époque de sa reproduction mécanisée“, in Essais, II, Parigi, Denoël-Gonthier, 1983).
Benjamin, Walter, “Geschichtsphilosophische Thesen und Briefe“, in Schriften, Suhrkamp, 1955 (trad. franc.: “Thèses sur la philosophie de l’histoire”, in Essais, II, Parigi, Denoël-Gonthier, 1983).
Berman, Marshall, All that is solid melts into air. The esperience of modernity, New York, 1982.
Bourdieu, Pierre, La responsabilità degli intellettuali, Roma-Bari, Laterza, 1991.
Bourriaud, Nicolas, Esthétique relationnelle, Digione, Les presses du réel, 1998.
Bourriaud, Nicolas, Postproduction. La culture comme scénario: comment l’art reprogramme le monde contemporain, Digione, Les presses du réel, 2003.
Brayer, Marie-Ange, “Cartes”, in catalogo della esposizione Archilab, Orléans, 2000.
Chiurazzi, Gaetano, Il postmoderno. Il pensiero nella società della comunicazione, Torino, Paravia, 1999.
Compagnon, Antoine, Les cinq paradoxes de la modernité, Parigi, Seuil, 1990.
De Carlo, Giancarlo, ”L’ultimo convegno dei CIAM. Con una ‘Memoria sui contenuti dell’architettura moderna’”, in G. D. C., Gli spiriti dell’architettura, Roma, Ed. Riuniti, 1999 (1992).
Desideri, Paolo, La città di latta. Favelas di lusso, autogrill, svincoli autostradali e antenne paraboliche, Genova, Costa&Nolan, 1997.
De Solà-Morales, Ignasi, “Oltre la critica radicale. Manfredo Tafuri e l’architettura contemporanea”, in I. De Solà-Morales, Decifrare l’architettura. ‘Inscripciones’ del XX secolo, Torino-Londra-Venezia, Allemandi, 2001, p. 131-142 (testo già pubblicato in Any, “Being Manfredo Tafuri”, n. 25-26, 2000, p. 56-60).
De Solà-Morales, Ignasi, ”Pratiche teoriche, pratiche storiche, pratiche architettoniche”, Zodiac, n. 21, 1999, p. 59.
Eisenman, Peter, Giuseppe Terragni: transformations, decompositions, critiques, New York, Monacelli Press, 2003.
Foster, Hal, The Return of the Real, Cambridge, The MIT Press, 1996.
Foster, Hal, Design & Crime, Londra, Verso, 2002.
Ghirardo, Diane, Architecture after Modernism, Londra, Thames&Hudson, 1996.
Gregotti, Vittorio, Le scarpe di Van Gogh. Modificazioni nell’architettura, Torino, Einaudi, 1994
Gregotti, Vittorio, Identità e crisi dell’architettura europea, Torino, Einaudi, 1999.
Harvey, David, The condition of postmodernity, Oxford, Basil Blackwell, 1990.
Ibelings, Hans, Supermodernism Architecture in the Age of Globalisation, Rotterdam, NAi Publishers, 1998.
Ilardi, Massimo (a cura di), La città senza luoghi. Individuo, conflitto, consumo nella metropoli, Genova, Costa&Nolan, 1997 (1990).
Ilardi, Massimo, “Il progetto, il politico, il potere”, Gomorra. Territori e culture della metropoli contemporanea, n. 4, 2002.
Jameson, Fredric, “Postmodernism, or the Cultural Logic of Late Capitalism”, New Left Review, n. 146,1984.
Lash, Scott, The Sociology of Postmodernism, Londres, Routledge, 1990.
Leach, Neal, The Anaesthetics of Architecture, Cambridge. Mass, M.I.T. Press, 1999.
Lo Ricco, Gabriella, Micheli, Silvia, Lo spettacolo dell’architettura. Profilo dell’archistar©, Milano, Mondadori, 2003
Manzione, Luigi, “A-topics, u-topics, eu-topics. La periferia e/è la città?”, Arch’it. Rivista digitale di architettura, 2000.
Masiero, Roberto, “Transarchitettura, ora”, Arch’it, 2001.
Nantois, Frédéric, “Lo stile informazionale in architettura” Arch’it, 2000.
Novak, Marcos, ”Speciazione, trasvergenza, allogenesi: note sulla produzione dell’alien”, in Livio Sacchi, Maurizio Unali, Architettura e cultura digitale, Milano, Skira, 2003. p. 141-155.
Ohmae, Kenichi, The Borderless World, New York, Harper&Collins, 1990.
Pavia, Rosario, Le paure dell’urbanistica. Disagio e incertezza nel progetto della città contemporanea, Genova, Costa&Nolan, 1997.
Perniola, Mario, Il sex appeal dell’inorganico, Torino, Einaudi, 1996.
Perniola, Mario, L’estetica del Novecento, Bologna, Il Mulino, 1997.
Perrella, Stephen, Hypersurface Architecture, New York, Academy Editions, 1998.
Purini, Franco, “I musei dell’iperconsumo”, Navigator, n. 6, 2002, p. 10-19.
Purini, Franco (a cura di), Generazioni e progetti culturali, Roma, Gangemi, 2007.
Ricci, Mosé (a cura di), Figure della trasformazione, Avezzano, Ed. D’Architettura, 1996.
Shinohara, Kazuo, “D’anarchie en bruit altatoire”, in Augustin Berque (a cura di), La qualité de la ville – Urbanité française, urbanité nipponne, Tôkyô, Maison franco-japonaise, 1987, p. 103-108.
Tafuri, Manfredo, La sfera e il labirinto. Avanguardie e architettura da Piranesi agli anni ‘70, Torino, Einaudi, 1980.
Tafuri, Manfredo, Teorie e storia dell’architettura, Roma-Bari, Laterza, 1986 (1968).
Töffler, Alvin, The Third Wave, New York, Bantam Books, 1981.
Vattimo, Gianni, La società trasparente, Milano, Garzanti, 1989.
Venturi, Robert, Izenour Steven, Scott Brown, Denise, Learning from Las Vegas, Cambridge. Mass, M.I.T. Press, 1972.
Virilio, Paul, L’espace critique, Parigi, Bourgois, 1984.
Riviste
Any, n. 23, 1998, “Diagram Work: Data Mechanics for a Topological Age”, in particolare gli articoli di Sanford Kwinter, “The Genealogy of Models: the Hammer and the Song”, p. 57-62 e di Robert E. Somol, “The Diagrams of Matter”, p. 23-26.
Area, n. 65, 2002 (dedicata ai musei, con i contributi al convegno sui “musei dell’iperconsumo” alla Triennale di Milano, 22 ottobre 2002).
