Diego Caramma_Architettura e società
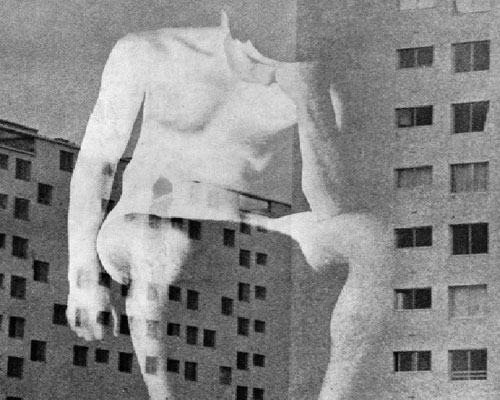
Le “webzines” commentano spesso articoli e recensioni di architettura riportate da settimanali e quotidiani, ma quasi mai riprendono i contenuti delle riviste di architettura. Se i settimanali stanno lentamente sostituendo le riviste senza che gli architetti se ne accorgano, bisogna chiedersi perché ciò accade. Ma è bene affrontare il discorso da due punti di vista, situati su due differenti livelli che però, ad un certo punto, si intrecciano.
Primo punto: l’interesse dei mass-media e dei settimanali nei confronti dell’architettura è dovuto al fatto che essa incrementa una cultura viva e operante, oppure, più semplicemente, i mezzi di comunicazione di massa ne registrano e amplificano la ricaduta in una fatua e retorica inerzia?
Secondo punto: si potrebbe supporre che il lessico dell’architettura moderna e contemporanea sia stato accettato o subìto anche dal pubblico e dal mondo ufficiale e dire: abbiamo conquistato la libertà di parola e il fatto che molti parlino anche a sproposito non ci preoccupa. Per cui salutiamo felici e beati l’evento e, senza farci troppi scrupoli e troppe domande, brindiamo felici e contenti.
Affrontiamo il primo punto. Supponiamo: ci troviamo in una situazione in cui vale la tesi secondo la quale nei momenti di prosperità (o nei momenti in cui si registra la psicologia di essa) la tensione di rinnovamento si attenua, e l’architettura rischia di perdere quota poiché, ristagnando, non progredisce e invecchia e, appunto perché invecchia, diventa immediatamente comprensibile e comunicabile senza alcuna fatica.
Se questa tesi trova conferma nella realtà, essa rappresenta solo una faccia della medaglia. Infatti esiste sempre un numero di professionisti decisi a rilanciare la professione lavorando creativamente e criticamente all’interno del paradigma dominante. Un nome su tutti: Toyo Ito.
Facciamo un piccolo passo in dietro. Fin dalla metà degli anni ‘60, si diceva che l’informatica avrebbe cambiato il modo in cui avremmo pensato, articolato il linguaggio, persino il modo in cui avremmo abitato. Il precedente sta nella scrittura alfabetica, che ci ha costretti a strutturare il nostro pensiero, organizzandolo.
È quindi pensabile che anche l’elettronica - quindi l’informatica, si pensi ad esempio all’ipertesto - faccia emergere caratteri nuovi. Se ci pensiamo, uno degli effetti, oggi, è quello di trovarci di fronte al continuo moltiplicarsi di reti per lo scambio e la distribuzione sul territorio di flussi di informazione, merci persone energie. Si tratta di un processo inarrestabile, che tuttavia ci offre gli strumenti per concepire l’architettura in modo diverso, come organismo in grado di espandersi e vibrare nell’ambiente. Si configura quindi un’importante possibilità di relazionare natura e architettura attraverso la tecnologia, ma tutto questo non può essere interpretato secondo i canoni dell’architettura tradizionale. Che di fronte al nuovo paradigma si sgretolano. Come del resto si sta sgretolando il nostro stesso alfabeto. È quindi presumibile che muti il modo in cui organizziamo il nostro pensiero.
È stato ampiamente dimostrato come esista una stretta relazione tra il modo in cui è organizzato il pensiero e lo spazio architettonico. Pensiamo solo al fatto che Gaston Bachelard ha scritto “La poetica dello spazio”, sostenendo come lo spazio della casa “sia uno dei più potenti elementi di integrazione per i pensieri, i ricordi ed i sogni dell’uomo”, ma indagando anche, nel medesimo libro, la dialettica fuori-dentro nelle molteplici chiavi di lettura.
Se questa relazione esiste, dobbiamo anche ammettere che quanto prodotto fino a questo momento è solo l’inizio di ciò verso cui ci potrebbe portare l’architettura.
Tuttavia dobbiamo osservare che se la gente oggi acquista senza difficoltà - e anzi esige - il telefonino di ultima generazione, o l’ultimo modello d’automobile, uno dei motivi, non diciamo l’unico, ma uno dei motivi è senz’altro quello che rende consapevoli le persone dell’utilità (non solo funzionale) di questi oggetti. Per quale motivo la medesima cosa non dovrebbe accadere con l’architettura? Perché, probabilmente, verso di essa non si sa trasmettere la stessa consapevolezza. Secondo cui si può acquisire la coscienza che l’architettura ha realmente la possibilità di migliorare le condizioni di vita dell’uomo - influendo nel costume e nel comportamento della gente, potenziando la capacità dell’uomo di abitare e gestire gli spazi, favorendo una maggiore fluidità, permeabilità e lettura degli ambienti di vita - che non equivale a dire che l’architettura sarebbe capace di rivoluzionare il mondo attraverso operazioni formali. La forma di un’automobile non riflette più la meccanica interna, ma il comfort della guida, il controllo automatico della localizzazione del veicolo attraverso navigatori satellitari, l’ergonomia, il controllo e la gestione del risparmio energetico, e così via.
Non è allora un caso se, circa quindici anni fa, Giovanni Michelucci scriveva: “se oggi il vero spazio del cittadino è costituito soprattutto dalla televisione, dall’automobile e dal campo sportivo, si tratta allora di partire da questi elementi primari per vedere se da essi possano ricostituirsi nuovi collegamenti, sino al punto da poter dare persino allo spazio domestico nuove attribuzioni”. Come sarà, allora, lo spazio che rifletterà l’idea di vita dell’età dell’elettronica? È forse ancora presto per dirlo, ma è tuttavia necessario capire che viviamo sull’onda di una storia sempre più accelerata, e l’esigenza di proteggersi da un’accelerazione troppo repentina degli eventi è ciò che fa tendere le persone alla reazione e a rifugiarsi nei miti consolatori del passato. È un istintivo bisogno, per certi versi anche sano, di autoconservazione, che però viene perseguito nel modo sbagliato, conferendo all’architettura un mero valore compensatorio e consolatorio. Uno degli sforzi sarà allora quello di considerare il bisogno di un’architettura che, attraverso la tecnologia, sappia relazionarsi alla natura lavorando sia all’interno del campo sensoriale sia in quello psicologico e intellettuale, rispondendo ai bisogni di velocità ma anche a quelli di lentezza, o quanto meno di rallentamento. Lavorando su alcune delle contraddizioni e antinomie dell’epoca presente, per esempio tra la superficialità della comunicazione o del mondo delle immagini e l’esigenza di profondità nella ricerca di valori simbolici; tra naturale e artificiale; tra corporeo e incorporeo. Risultati che si potranno acquisire lavorando criticamente all’interno del paradigma dominante, utilizzando gli strumenti che esso ci mette a disposizione. Senza ciniche evasioni, né tanto meno facili illusioni.
Veniamo al secondo punto. In sostanza, è un problema di linguaggio, o di qualità e quindi di tensione culturale? Si tratta di fruizione consapevole, o di “fruizione distratta” degli spazi di vita contemporanei? - come direbbe Umberto Eco parafrasando Walther Benjamin. Le scelte poggiano su una palpitante coscienza dell’arte contemporanea, dalla quale poter trarre alimento critico, o seguono le mode del momento, che cambiano da un giorno all’altro?
Se, come abbiamo detto, la sfida è quella di lavorare su un nuovo rapporto tra natura architettura e tecnologia, allora il problema non è più quello del linguaggio ma quello di acquistare una nuova consapevolezza. Per cui, il discorso verte sulla qualità e deve alimentare una tensione culturale che rifugga da banalizzazioni. Quanto al problema della fruizione, bisogna ammetterlo: nella maggior parte dei casi si tratta di “fruizione distratta” dell’architettura da parte degli utenti. Dubitiamo anche che le scelte non siano dettate dalle mode effimere.
Complici anche le riviste di architettura che, in un mercato ormai inflazionato, diventano merce di scambio, calcolo, investimento. Ridotte a dei cataloghi, a magazine da sfogliare in cinque minuti e poi richiudere, non possiedono, salvo rare eccezioni, apparati teorici stimolanti, per non parlare dell’assenza di quelli critici e storico/critici. Se le riviste non sono in grado di puntare sul processo creativo - mettendo in luce il percorso di formazione di un progetto, illustrandone la genesi dall’interno - ma si limitano a parlare del risultato finale di una ricerca venduta (magari anche senza volerlo) come ricerca formale fine a se stessa, come pensiero già formato, come si può pretendere che la gente comune ma, forse, prima ancora gli architetti, acquistino la necessaria consapevolezza di fronte all’architettura?
Torniamo per un attimo a Toyo Ito. In un articolo del 1993, intitolato “Un giardino di microchip”, dirà: abbiamo superato l’età della meccanica, ma non abbiamo ancora cambiato l’organizzazione funzionalistica e meccanicistica delle abitazioni. Non abbiamo ancora trovato - in sostanza - uno spazio che rifletta l’idea di vita nell’età dell’elettronica.
Riflettiamo: com’è noto, i messaggi di questa epoca sono sempre più traslati, metaforici, e sempre meno assertivi. Pensiamo alla pubblicità. Quella del mondo industriale asseriva: questa automobile è più veloce, o e più funzionale. Oggi i messaggi sono altri e d’altro tipo: il prodotto non viene neppure descritto. Viene venduta l’idea che esso ottempererà le richieste del consumatore attraverso l’associazione o l’uso di figure retoriche. Pensiamo alle ultime pubblicità della Seat Ibiza, o della Ford, o della Renault, o della Peugeot. È un processo basato sulle interconnessioni dinamiche della metafora, che investe ogni campo.
Nell’architettura serve ancora del tempo per superare e andare oltre l’idea che un edificio sia solo “intelligente”, che trasformi i muri in membrane provviste di sensori che reagiscono con l’ambiente, anche esterno, ricevendo e ritrasmettendo informazioni dopo averle rielaborate. L’architettura di cui parla Ito, invece, è quella che sarà in grado di generare altre metafore: quelle capaci di spazializzare e concretizzare il divenire della vita e del pensiero che in essa si svolge. L’essenza di tutto ciò, come è stato detto, è il principio antichissimo del divenire.
Concludiamo. Concordano tutti sul fatto che il compito dei critici e degli architetti non è quello di prevedere la storia, ma quello di prepararne e accoglierne i movimenti. In tal senso si può comprendere anche ciò che intendeva Edoardo Persico quando, il 21 gennaio del 1935, proprio a Torino, durante una conferenza memorabile intitolata “Profezia dell’architettura”, diceva: “anch’io penso talvolta a una storia dell’architettura che s’identifichi con quella stessa dell’uomo moderno”. Fede segreta di un’epoca, “sostanza di cose sperate”, “garanzia più certa di una civiltà”.
È evidente che non occorre difendere la realtà così com’è, ma neppure cadere nel masochismo del “tutto va male”. Una cultura su cui puntare, esiste e produce. Si tratta di farla prevalere. Ma senza appiattirla e registrarla in modo acritico e, spesso, distratto.
[Diego Caramma]
